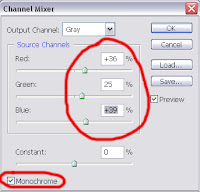Per la fotografia di paesaggio i filtri ottici, in piena era digitale, sono ancora indispensabili per ottenere fotografie naturali e di assoluto valore tecnico ed estetico. Usandoli ormai da diverso tempo ho acquisito una certa familiarità con essi e spesso mi chiedono chiarimenti sui filtri che utilizzo: i Cokin serie P. La Cokin produce varie serie di filtri: A, P, Z-PRO, X-PRO. La discriminante tra le varie serie è principalmente la dimensione massima dei filtri utilizzabili. In particolare le serie Z-PRO e X-PRO sono adatte alle fotocamere medioformato, molto più grandi delle normali reflex, oppure per reflex con obiettivi ultragrandangolari, in cui è importante il problema della vignettatura dovuta al portafiltri Cokin sulle serie A e P. Per le reflex digitali la serie P (per diametri di filettatura esterna fino a 82mm) è quella più diffusa, anche se sono noti i problemi con le lenti ultragrandangolari di cui mi occuperò più avanti nell'articolo. D'ora in avanti mi riferirò esclusivamente alla serie P.
Ogni serie di filtri Cokin è basata sul principio che tutti i filtri del sistema possono essere montati su tutti gli obiettivi in nostro possesso; viene sfruttato un particolare sistema, come mostrato in
Figura 1 [
fonte]. Un anellino adattatore viene avvitato sull'obiettivo. L'anello adattatore ha un diametro esterno di valore fisso, che viene sfruttato per incastrarci il portafiltri. Sul portafiltri vengono inseriti i filtri. Il vantaggio è quindi quello di avere un solo filtro e poterlo montare su più di un obiettivo, semplicemente cambiando il solo anello adattatore.
 Figura 1
Figura 1:
Sistema Cokin serie PNel portafiltri standard, denominato holder, ci sono 3 slot normali ed un intaglio in cui è possibile inserire:
- Lastrine (nelle slot)
- Polarizzatore di forma tondeggiante (nell'intaglio)
Ogni filtro viene denominato con una sigla alfanumerica del tipo PNNN, in cui il numero "NNN" denomina univocamente il tipo di filtro. Il polarizzatore è unico per tutta la serie ed è identificato dalla sigla P164 (anche se ne esistono alcune vcarianti colorate). Si tratta di un filtro in vetro sulla cui circonferenza esterna c'è una lamina seghettata che è utile per ruotare facilmente il polarizzatore nel suo intaglio.
Le lastrine che più si utilizzano nella fotografia di paesaggio sono i filtri neutri e i filtri digradanti (altresì conosciuti come graduati); sono invece inutili i filtri colorati che si utilizzavano con la pellicola.
I
filtri neutri sono delle lastrine opache, la cui opacità è legata alla quantità di luce che il filtro è in grado di bloccare. Servono quindi ad allungare i tempi di esposizione quando richiesto per motivi tecnici o espressivi. L'entità dell'opacità è detta
graduazione e si misura in
stop di esposizione (EV). In Cokin la graduazione si misura con le sigle
ND2,
ND4 e
ND8 , che corrispondono a 1, 2 e 3 EV rispettivamente (equivalenti alle sigle 0.3, 0.6, 0.9 per altre marche di filtri).
Principali sigle [fonte]:
- P152 : ND2: 1 stop
- P153: ND4: 2 stop
- P154: ND8: 3 stop
I
filtri digradanti, o
graduati (
graduated in inglese), sono lastrine che hanno una parte opaca che sfuma in una parte trasparente. La sfumatura avviene
tipicamente a metà del filtro. La parte trasparente non influisce sull'esposizione, mentre quella opaca ha lo stesso effetto di un filtro neutro. Questi filtri sono spesso usati per compensare le differenze di esposizione tra cielo e terra, in modo da ottenere una foto perfettamente esposta senza nessuna doppia esposizione o HDR. La graduazione è la stessa dei filtri neutri e quindi avremo i
Graduated ND2 ,
(G) ND4 e
(G) ND8 , che corrispondono a 1, 2 e 3 EV rispettivamente (equivalenti alle sigle 0.3, 0.6, 0.9 per altre marche di filtri).
Principali sigle [
fonte]:
- P120: GND2: 1 stop (sulla carta è un po' più di 1 stop)
- P121: GND8: 3 stop
- P121L: GND2: 1 stop
- P121M: GND4: 2 stop
- P121S: GND8: 3 stop
- P121F: GND8: 3 stop con gradazione che si sviluppa lungo tutta la lastrina (usi specifici)
Di solito utilizzo alcuni di questi filtri in abbinata: il polarizzatore P164 (utile per eliminare i riflessi e saturare i colori) con una o due lastrine in base alle necessità di esposizione. In generale sono molto utili il P120 per le esposizioni durante il giorno pieno e poco prima del tramonto. Per il tramonto torna molto utile il P121, da 3 stop.
Vignettatura con ultragrandangoli:Nel paesaggio i grandangoli sono molto utilizzati e questo ha delle ripercussioni sull'uso dei filtri. Si ha infatti il problema della vignettatura meccanica, in cui parte del portafiltri o addirittura del polarizzatore entrano nell'inquadratura a causa dell'ampio angolo di campo dell'obiettivo unito allo spessore del sitema. L'effetto è molto sgradevole, come si vede in Figura 2 (cliccare per ingrandire). In questo caso ho scattato con polarizzatore e una lastrina a 14 mm. A 12mm l'effetto è molto più pronunciato.
 Figura 2: vignettatura "meccanica"
Figura 2: vignettatura "meccanica"Come già accennato, i filtri serie P hanno dei notevoli problemi da questo punto di vista. Per
esperienza personale posso dire che si può usare il portafiltri standard solo per focali
da 15mm in poi su formato digitale APS-C (Nikon DX). Questo causa ovviamente problemi con grandangoli del tipo 12-24 o, ancora peggio, 10-20 su DX. Su fomato fullframe (Nikon FX) si ha lo stesso problema con obiettivi come il 17-35 e simili. E' possibile trovare in negozi ben forniti un holder
"wide-angle", dotato di un solo slot e di un solo intaglio, ma anch'esso vignetta con lastrina fino a 12mm e con polarizzatore fino a 14mm, a causa dello spessore intrinseco del P164. Per poter scattare alla focale minima dei nostri grandangoli ci sono due soluzioni.
La prima è quella di tenere le lastrine a mano davanti all'obiettivo: in questo caso si è molto scomodi e si rischia di non ottenere buoni risultati, perdendo magari delle belle fotografie, ma la situazione migliora con un po' di esperienza; c'è anche il richio che i filtri ci cadano di mano con conseguenze disastrose.
La seconda soluzione è passare ad un sistema di filtri più grandi come il Cokin Z-PRO, il Cokin X-PRO o il migliore LEE. In questo caso però i filtri e gli holder avranno un costo notevolmente più alto, giustificato da un uso intenso e con perfetta cognizione di causa.
Attenzione particolare va fatta anche a riguardo del
sistema di filtri Lee, che in questo caso non analizzo nel dettaglio in quanto non in mio possesso. Tuttavia ho potuto vedere dei test effettuati con questo sistema di filtri. Premetto che nel sistema Lee l'holder, a differenza dei Colkin serie P, è assemblabile con un numero variabile di slots tramite delle guide fissate da vitine.
In particolare, utilizzando solo lastrine digradanti non si ha nessuna vignettatura neanche con tutti gli slot montati a 17mm sul formato pieno fullframe (
Nikon FX), con l'unico accorgimento di utilizzare un anello adattatore del tipo "wide angle". Il polarizzatore invece può dare dei problemi, in quanto montato dalla parte opposta rispetto alla lente frontale dell'obiettivo. pur utilizzando anelli adattatori
wide-angle. In tal caso, usando polarizzatori normali (Lee o B+W da 105 mm), si incorre nella vignettatura solo usando due slot alla minima focale di 17 mm. Da 19 mm la vignettatura è praticamente del tutto eliminata anche usando due slots e il polarizzatore B+W.
Con un solo slot invece la vignettaura viene praticamente evitata. Nella foto seguente viene mostrato un confronto diretto a 17 mm su fullframe (equivalente a poco meno di 12mm su DX). Ringrazio il gentilissimo
Salvatore Maione, che ha eseguito il test e mi ha fornito i risultati. Consiglio la visione del suo
portfolio su pbase per apprezzare le sue foto e avere tanti esempi d'uso di filtri Lee su Nikon D700 FX.
 Dominanti:
Dominanti:Altro problema noto per questi filtri è la comparsa di una dominante magenta nell'uso di almeno due lastrine neutre contemporaneamente. Questo implica che i Cokin non sono propriamente dei filtri neutri al 100% come lo sono invece i professionali Lee o Singh-Ray. L'entità di questo problema è più pronunciato nelle fotocamere più vecchie e/o di fascia base, probabilmente a causa delle caratteristiche del sensore. Per esempio su macchine come la Nikon D200 o D300 il fenomeno è scarsamente avvertibile se comparato ad una D70. Nella fotografia al tramonto, in cui la luce ha colori caldi, questo effetto potrebbe essere anche gradevole, ma con una luce diversa diventa fastidioso.
Conclusioni:Nonostante i difetti di cui ho parlato, reputo i Cokin un ottimo prodotto. Sicuramente sono una soluzione economica che funziona perfettamente per ottenere belle fotografie, prima impensabili, e per impare ad usare i filtri. Per consigli, chiarimenti o semplicemente per sapere dove acquistarli potete contattarmi tramite e-mail all'indirizzo indicato nelle sezione contatti. Le foto scattate utilizzando i filtri in questione sono rintracciabili utilizzando la ricerca per etichette (filtri gnd e polarizzatore) del blog.
Aggiornamento 3 Settembre 2008:Ho scritto un post di approfondimento sui filtri, con ulteriori chiarimenti, riflessioni ed immagini. Potete cliccare su questo link: